Aconitum anthora L.

Phylum: Tracheophyta Sinnott, 1935 ex Cavalier-Smith (1998)
Classe: Magnoliopsida Brongn. (1843)
Ordine: Ranunculales Juss. ex Bercht. & Presl J. (1820)
Famiglia: Ranunculaceae Juss., 1789
Genere: Aconitum L.
Italiano: Aconito antora
English: Yellow Monkshood
Français: Aconit anthore
Deutsch: Gift-Eisenhut
Español: Acónito de los Alpes, Acónito salutífero
Descrizione
Il nome del genere (“Aconitum”) deriva dal greco akòniton (= “pianta velenosa”). La pianta infatti risulta conosciuta per l'alta sua tossicità fin dai tempi dell'antichità omerica. Con questo nome probabilmente veniva indicata una pianta velenosa endemica il cui habitat frequente era tra le rocce ripide di alcune zone della Grecia. Due sono le radici che vengono attribuite al nome: akòne (= “pietra”) facendo riferimento al suo habitat; koné (= “uccidere”), facendo ovviamente riferimento alla sua tossicità. Veniva anche usata come simbolo negativo (maleficio o vendetta) nella mitologia dei popoli mediterranei. Il nome specifico deriva (sempre dal greco) dalla radice anthòs (= “fiore”) (insieme all'epiteto generico può quindi significare: “fiore velenoso”). Il binomio scientifico attualmente accettato (Aconitum anthora) è stato proposto da Carl von Linné (1707 - 1778) biologo e scrittore svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi, nella pubblicazione ”Species Plantarum” del 1753. Sono piante erbacee, perenni la cui altezza può arrivare da 5 a 10 dm. La forma biologica è definita come geofita rizomatosa (G rhiz), ossia sono piante che portano le gemme in posizione sotterranea. Durante la stagione avversa non presentano organi aerei e le gemme si trovano in organi sotterranei come rizomi, un fusto sotterraneo dal quale, ogni anno, si dipartono radici e fusti aerei. Radici: sono secondarie da rizoma. Fusto: parte ipogea: la parte sotterranea è un rizoma ingrossato e tuberoso. Parte epigea: la parte aerea del fusto è eretta (ascendente e cilindrica) e pubescente. Foglie: le basali sono del tipo 3 - 4 palmatosette con margini profondamente incisi. I segmenti terminali sono delle lacinie lineari larghe 1 - 2 mm. Le foglie cauline sono disposte in modo alterno e sono progressivamente più piccole con un minore di segmenti. Infiorescenza: è una pannocchia terminale del tipo a racemo. È sia ramosa che fogliosa soprattutto alla base. I fiori sono peduncolati; la lunghezza dei peduncoli è minore dei fiori stessi. Altezza dell'infiorescenza: 10 - 15 cm. Fiore: sono considerati fiori arcaici, o perlomeno derivati da fiori più arcaici dalla struttura aciclica. Il perianzio è formato da due verticilli: gli elementi esterni hanno una funzione di protezione e sono chiamati tepali o sepali (la distinzione dei due termini in questo caso è ambigua e quindi soggettiva); quelli interni sono dei nettari (in questo fiore la corolla è praticamente assente). I fiori sono pentameri (a cinque elementi) a simmetria zigomorfa (o bilaterale). In questi fiori il calice non è speronato. Il colore del perianzio è giallo (pallido). Altezza del fiore: 15 - 20 mm. Formula fiorale: per questa pianta viene indicata la seguente formula fiorale: x K 5, C 2, A numerosi, G 5 (supero) Calice: il calice ha cinque sepali (o tepali) di tipo petaloideo, molto diversi fra loro, di cui il superiore ha la forma di elmo o casco a geometria emisferica con alla base un prolungamento a forma di becco. Degli altri sepali due hanno una disposizione laterale a forma ovale; i due inferiori sono più lineari e lanceolati. I sepali non sono persistenti alla fruttificazione. Dimensione del casco: altezza 8 - 12 mm; larghezza 14 - 16 mm. Lunghezza del becco del casco: 1/3 del totale. Corolla: praticamente assente; i petali interni 2 (raramente 5) sono delle foglie trasformate in produttori di nettare ed hanno una forma cilindrica spiraleggiante un po' clavata (a martelletto). Androceo: gli stami (scuri) sono numerosi (da 25 a 50) a disposizione spiralata. Gineceo: i carpelli (sessili e spiralati) sono 5 (raramente di meno). I pistilli contengono da 10 a 20 ovuli. Fioritura: da agosto a settembre. Frutti: il frutto è costituito da un aggregato di 5 capsule o follicoli sessili e polispermi (frutto secco sviluppato longitudinalmente con delle fessure per la fuoriuscita dei semi). Ogni follicolo termina con un becco diritto di 2 - 3 mm. Riproduzione: l'impollinazione è garantita soprattutto da diversi insetti, come api e vespe in quanto sono piante nettarifere (impollinazione entomogama). La fecondazione avviene sia tramite l'impollinazione dei fiori (vedi sopra), ma anche per divisione del piede (propagazione tipicamente orticola).
Diffusione
Geoelemento: il tipo corologico (area di origine) è Orofita - Sud Europeo. Distribuzione: si trova raramente solo nelle Alpi in quasi tutte le province (escluse BZ, SO, UD, TV). Fuori dall'Italia (sempre nelle Alpi) si trova in Francia (dipartimenti di Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme, Isère, Savoia, Alta Savoia) e in Austria (Länder della Stiria e Austria Inferiore). Sugli altri rilievi europei si trova nel Massiccio del Giura, Massiccio Centrale, Pirenei, Alpi Dinariche, Monti Balcani e Carpazi. È presente anche in Asia temperata. Habitat: l'habitat tipico sono le stazioni aride e rupestri; ma anche praterie, prati e pascoli dal piano collinare a quello subalpino. Il substrato preferito è calcareo con pH basico, medi valori nutrizionali del terreno che deve essere secco. Distribuzione altitudinale: sui rilievi queste piante si possono trovare dai 300 fino a 1500 m s.l.m. (raramente fino a 2000 m s.l.m.); frequentano quindi i seguenti piani vegetazionali: montano e subalpino. Fitosociologia: dal punto di vista fitosociologico la specie di questa voce appartiene alla seguente comunità vegetale: Formazione: delle comunità delle macro- e megaforbie terrestri Classe: Trifolio-Geranietea sanguinei Ordine: Origanetalia vulgaris Alleanza: Geranion sanguinei.
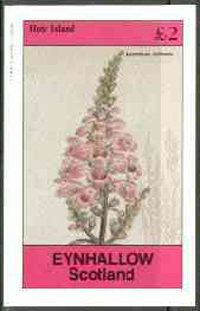
|
Stato: Scotland |
|---|